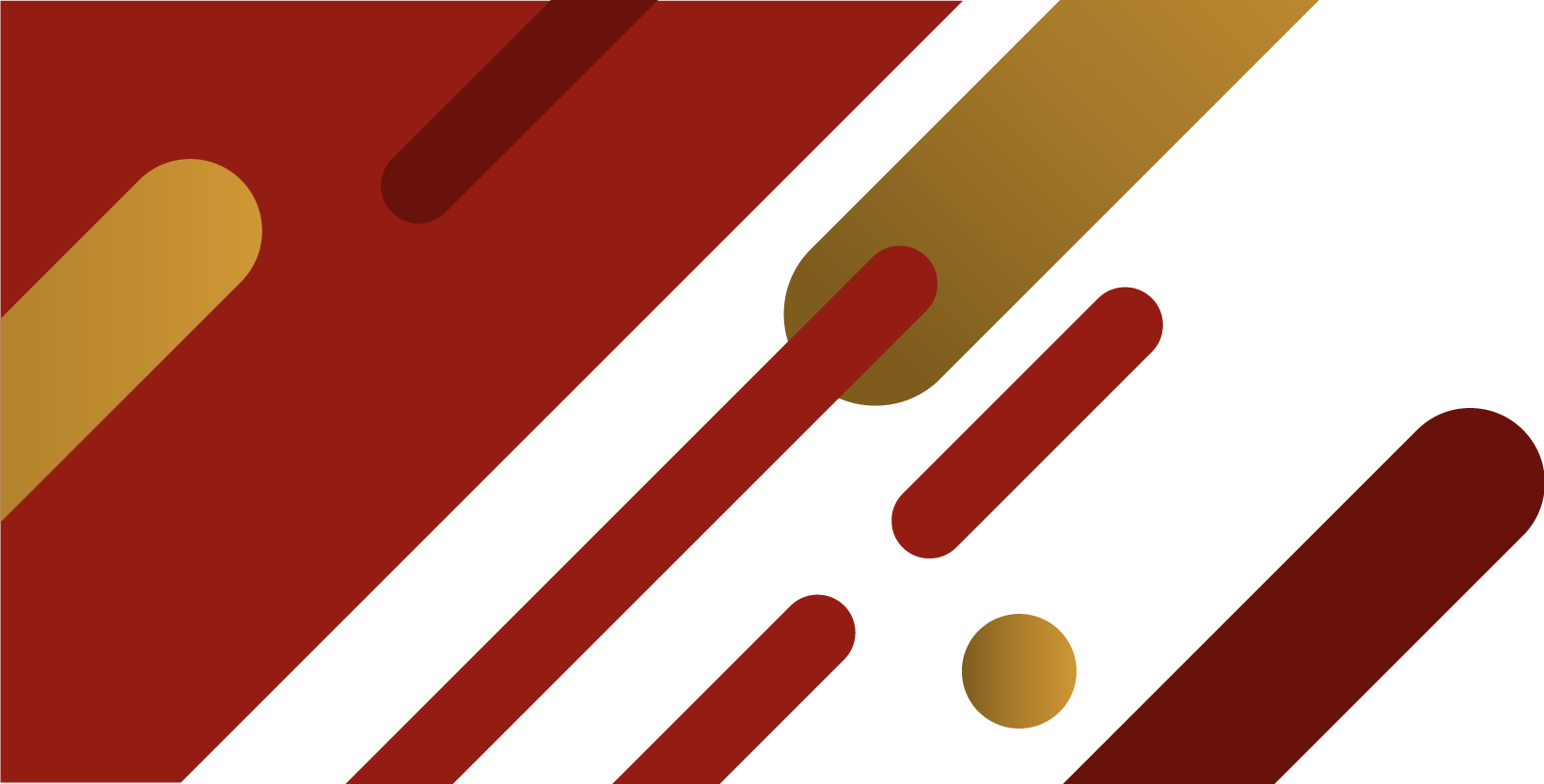Premessa - In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del sito con riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali - Per tutti gli utenti del sito web i dati personali
potranno essere utilizzati per:
- - permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del sito web;
- - controllare il corretto funzionamento del sito web.
COOKIES
Che cosa sono i cookies - I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti
web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.
Tipologie di cookies - Si informa che navigando nel sito saranno scaricati cookie definiti tecnici, ossia:
- cookie di autenticazione utilizzati nella misura strettamente necessaria al fornitore a erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente;
- cookie di terze parti, funzionali a:
PROTEZIONE SPAM
Google reCAPTCHA (Google Inc.)
Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. Questo tipo di
servizio analizza il traffico di questa Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali
degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come
SPAM.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy
policy del servizio.
Privacy Policy
VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne
direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli
Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in
cui è installato.
Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.
Privacy Policy
Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all'interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Dati di Utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato
dalla privacy policy del servizio.
Privacy Policy
Come disabilitare i cookies - Gli utenti hanno la possibilità di rimuovere i cookie in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
I cookies memorizzati sul disco fisso del tuo dispositivo possono comunque essere cancellati ed è inoltre possibile disabilitare i cookies seguendo le indicazioni fornite dai principali browser, ai link seguenti:
Base giuridica del trattamento - Il presente sito internet tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la
consultazione del presente sito internet l’interessato acconsente implicitamente alla possibilità di
memorizzare solo i cookie strettamente necessari (di seguito “cookie tecnici”) per il funzionamento di questo
sito.
Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un
eventuale rifiuto - Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log file, nei quali vengono conservate
informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte
potrebbero essere le seguenti:
- - indirizzo internet protocollo (IP);
- - tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
- - nome dell'internet service provider (ISP);
- - data e orario di visita;
- - pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il corretto
funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.
Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono
eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato,
conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo
o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai
utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre
la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della
risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo dell'utente.
Tempi di conservazione dei Suoi dati - I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per
il tempo necessario a svolgere le attività precisate e non oltre 24 mesi.
Modalità del trattamento - Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, i dati personali degli
interessati saranno registrati, trattati e conservati presso gli archivi elettronici delle Società, adottando
misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi. Il trattamento dei dati personali degli
interessati può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate all' art. 4,
comma 1, punto 2 del GDPR.
Comunicazione e diffusione - I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati, intendendosi con
tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dalla Società a terzi per dare attuazione
a tutti i necessari adempimenti di legge. In particolare i dati personali dell’interessato potranno essere
comunicati a Enti o Uffici Pubblici o autorità di controllo in funzione degli obblighi di legge.
I dati personali dell’interessato potranno essere comunicati nei seguenti termini:
- - a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
- - a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra
l’interessato e la Società, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.
Diritti dell’interessato - Ai sensi degli artt. 15 e ss GDPR, l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti:
- 1. accesso: conferma o meno che sia in corso un trattamento dei dati personali dell’interessato e diritto
di accesso agli stessi; non è possibile rispondere a richieste manifestamente infondate, eccessive o
ripetitive;
- 2. rettifica: correggere/ottenere la correzione dei dati personali se errati o obsoleti e di completarli, se
incompleti;
- 3. cancellazione/oblio: ottenere, in alcuni casi, la cancellazione dei dati personali forniti; questo non è
un diritto assoluto, in quanto le Società potrebbero avere motivi legittimi o legali per conservarli;
- 4. limitazione: i dati saranno archiviati, ma non potranno essere né trattati, né elaborati ulteriormente,
nei casi previsti dalla normativa;
- 5. portabilità: spostare, copiare o trasferire i dati dai database delle Società a terzi. Questo vale solo per
i dati forniti dall’interessato per l’esecuzione di un contratto o per i quali è stato fornito consenso e
espresso e il trattamento viene eseguito con mezzi automatizzati;
- 6. opposizione al marketing diretto;
- 7. revoca del consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul consenso.
Ai sensi dell’art. 2-undicies del D.Lgs. 196/2003 l’esercizio dei diritti dell’interessato può essere ritardato,
limitato o escluso, con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che la comunicazione possa
compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura
necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al
fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a) (interessi tutelati in materia di riciclaggio),
e) (allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria)ed f) (alla
riservatezza dell’identità del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del
proprio ufficio). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le
modalità di cui all’articolo 160 dello stesso Decreto. In tale ipotesi, il Garante informerà l’interessato di aver
eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame nonché della facoltà dell’interessato di
proporre ricorso giurisdizionale.
Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi alla nostra Struttura "Titolare del trattamento dei dati personali"
all'indirizzo ssdirittodellacrisi@gmail.com oppure inviando una missiva a Società per lo studio del diritto
della crisi via Principe Amedeo, 27, 46100 - Mantova (MN). Il Titolare Le risponderà entro 30 giorni dalla
ricezione della Sua richiesta formale.
Dati di contatto - Società per lo studio del diritto della crisi con sede in via Principe Amedeo, 27, 46100 -
Mantova (MN); email: ssdirittodellacrisi@gmail.com.
Responsabile della protezione dei dati - Il Responsabile della protezione dei dati non è stato nominato
perché non ricorrono i presupposti di cui all’art 37 del Regolamento (UE) 2016/679.
Il TITOLARE
del trattamento dei dati personali
Società per lo studio del diritto della crisi
REV 02