
Giovanni La Croce, Dottore Commercialista in Milano
La richiesta cautelare d’inibizione dell’escussione delle garanzie statali: l’harakiri del ristrutturatore.
19 Settembre 2025
In particolare, piacciono ai suoi legislatori.
Se il precetto è chiaro il rapporto Stato - cittadino è un rapporto democratico-partecipativo, se la disposizione è oscura il rapporto è di sudditanza.
E si sa, i sudditi, rispetto ai cittadini, sono più facili da gestire.
Ossia considerare l’escussione non una certezza e, in conseguenza, classificare il credito come chirografo, stanziando un corrispondente fondo rischi di escussione, quando si sa a priori che l’escussione interverrà.
Eppure, se tale ricostruzione ermeneutica, che a mio parere è una delle più felici intuizioni dell’illustre autore, fosse stata condivisa, molte delle problematiche che la norma riflette nell’ambito delle ristrutturazioni aziendali sarebbero state eliminate a monte, quanto meno in tutti quei casi in cui l’ambiente fosse stato di tipo concorsuale.
Ma tant’è.
Circostanza questa che, sola, pone l’ente garante nella condizione di valutare la convenienza di un trattamento deteriore rispetto a quello che il super privilegio teoricamente gli assicurerebbe.
Altro che super privilegio per ragioni di Stato.
Se così fosse, infatti, sarebbe la mancanza di una base concreta, compatibile con il piano economico, per avviare tempestivamente le trattative con i creditori a dover indurre l’esperto, non solo ad esprimere il proprio parere negativo sull’inibitoria per le ragioni sopra dette, bensì anche a richiedere al segretario generale della Camera di commercio l’archiviazione del procedimento per assenza delle necessarie ragionevoli condizioni per il perseguimento del risanamento.
22 Settembre 2025 9:13
4 Ottobre 2025 20:57
5 Ottobre 2025 18:28
Anzi, riflettendoci bene, il diritto di regresso con super privilegio fu pensato proprio per evitare un’ impugnativa sotto tale profilo da parte della Commissione UE.
Maggiore è lo stralcio accettato dalla banca, maggiore sarebbe il sacrificio imposto a MCC, con un pericoloso effetto regressivo al di fuori da qualsiasi cornice normativa.
Tutto su base puramente discrezionale, poi!
A proposito, cosa dice la “sura” di Sace?
Ad esempio essa sarebbe praticabile solo nella CN e negli AdR base, non in quelli a efficacia estesa, e non nel concordato preventivo, né tanto meno nella liquidazione giudiziale.
7 Ottobre 2025 19:24
Anzi, riflettendoci bene, il diritto di regresso con super privilegio fu pensato proprio per evitare un’ impugnativa sotto tale profilo da parte della Commissione UE.
Maggiore è lo stralcio accettato dalla banca, maggiore sarebbe il sacrificio imposto a MCC, con un pericoloso effetto regressivo al di fuori da qualsiasi cornice normativa.
Tutto su base puramente discrezionale, poi!
A proposito, cosa dice la “sura” di Sace?
Ad esempio essa sarebbe praticabile solo nella CN e negli AdR base, non in quelli a efficacia estesa, e non nel concordato preventivo, né tanto meno nella liquidazione giudiziale.
concordo anzitutto con il fatto che le Disposizioni Operative dovrebbero essere aggiornate in coerenza con le modifiche introdotte e con le novità apportate dal Codice della Crisi.
Allo stato della normativa, anche regolamentare, ritengo che l'ipotesi di responsabiltà erariale da parte dell'ente garante possa essere esclusa nella misura in cui, a fronte di proposte di accordo a saldo e stralcio, è necessario che le stesse siano corredate da un parere motivato di un professionista indipendente circa la reale convenienza di tale proposta rispetto ad altri scenari alternativi. In questo modo, l'accoglimento della proposta di saldo e stralcio da parte dell'ente garante, se è vero che diminuisce la recovery finale, tuttavia consente una minima forma di soddisfazione ed evita all'ente medesimo di vedersi riconosciuto un super privilegio sulla carta, ma senza alcuna possibilità di essere soddisfatto.
7 Ottobre 2025 23:13
concordo anzitutto con il fatto che le Disposizioni Operative dovrebbero essere aggiornate in coerenza con le modifiche introdotte e con le novità apportate dal Codice della Crisi.
Allo stato della normativa, anche regolamentare, ritengo che l'ipotesi di responsabiltà erariale da parte dell'ente garante possa essere esclusa nella misura in cui, a fronte di proposte di accordo a saldo e stralcio, è necessario che le stesse siano corredate da un parere motivato di un professionista indipendente circa la reale convenienza di tale proposta rispetto ad altri scenari alternativi. In questo modo, l'accoglimento della proposta di saldo e stralcio da parte dell'ente garante, se è vero che diminuisce la recovery finale, tuttavia consente una minima forma di soddisfazione ed evita all'ente medesimo di vedersi riconosciuto un super privilegio sulla carta, ma senza alcuna possibilità di essere soddisfatto.
La ringrazio per aver posto fine alla singolar tenzone in cui ci eravamo imbarcati.
Non mi compiaccio del fatto che la sua interpretazione sia sovrapponibile alla mia, ma colgo la sua giusta riflessione sulla possibilità per il funzionario di basarsi sull'attestazione di convenienza.
Diversamente ragionando non vedo come colui che funzionario pubblico lo è senza ombra di dubbio (direttore regionale ADE) dovrebbe poter sottoscrivere una transazione fiscale mentre il funzionario MCC non potrebbe farlo.
Mi dispiace insistere sulla fallacia di alcuni argomenti giustapposti nella tesi dell'esimio collega La Croce.
Non posso tacere che l'appellativo di "eversiva" dato alla mia interpretazione mi sembra altisonante quanto immeritato.
Circa il contrasto normativo tra la norma secondaria regolamento disposizioni operative MCC ( ex DM MIMIT decreto ministeriale del 2 agosto 2023 ) norma primaria e disciplina unionale, lascio l'interpretazione agli uffici legali delle banche ed agli organi giurisdizionali in quanto io mi limito a ragionare de jure condito.
Nel mio sommesso e circoscritto intervento intendo ribadire che :
1) Le disposizioni operative (redatte ante CCII) andrebbero completamente riviste (proprio per una armonizzazione al nuovo CCII) per valorizzare il ruolo di esperti ed attestatori che hanno il compito di mettere in evidenza come la perdita di MCC (che è una perdita per la collettività) può essere contenuta al minimo;
Ripeto che nessuno di noi dispone della verità e che il nuovo codice dell'insolvenza mette tutti davanti ad un notevole sforzo interpretativo. Con questo spirito vi invito tutti a leggere "IL RUOLO DELLE PARTI E DEI PROFESSIONISTI NEL FILM DELLA CRISI DI IMPRESA" del prof. Fabiani su questa rivista. Con questa lettura possiamo meglio interpretare la sceneggiatura della crisi che può vedere il singolo professionista vestire i panni di Advisor in un procedimento, di Attestatore in altro e di Esperto in altro ancora. Forse il grande interprete deve sapersi calare nelle diverse parti abbandonando ogni preconcetto, ogni ragionamento apodittico (lo dico anche a me stesso, of course).
8 Ottobre 2025 14:45
La ringrazio per aver posto fine alla singolar tenzone in cui ci eravamo imbarcati.
Non mi compiaccio del fatto che la sua interpretazione sia sovrapponibile alla mia, ma colgo la sua giusta riflessione sulla possibilità per il funzionario di basarsi sull'attestazione di convenienza.
Diversamente ragionando non vedo come colui che funzionario pubblico lo è senza ombra di dubbio (direttore regionale ADE) dovrebbe poter sottoscrivere una transazione fiscale mentre il funzionario MCC non potrebbe farlo.
Mi dispiace insistere sulla fallacia di alcuni argomenti giustapposti nella tesi dell'esimio collega La Croce.
Non posso tacere che l'appellativo di "eversiva" dato alla mia interpretazione mi sembra altisonante quanto immeritato.
Circa il contrasto normativo tra la norma secondaria regolamento disposizioni operative MCC ( ex DM MIMIT decreto ministeriale del 2 agosto 2023 ) norma primaria e disciplina unionale, lascio l'interpretazione agli uffici legali delle banche ed agli organi giurisdizionali in quanto io mi limito a ragionare de jure condito.
Nel mio sommesso e circoscritto intervento intendo ribadire che :
1) Le disposizioni operative (redatte ante CCII) andrebbero completamente riviste (proprio per una armonizzazione al nuovo CCII) per valorizzare il ruolo di esperti ed attestatori che hanno il compito di mettere in evidenza come la perdita di MCC (che è una perdita per la collettività) può essere contenuta al minimo;
Ripeto che nessuno di noi dispone della verità e che il nuovo codice dell'insolvenza mette tutti davanti ad un notevole sforzo interpretativo. Con questo spirito vi invito tutti a leggere "IL RUOLO DELLE PARTI E DEI PROFESSIONISTI NEL FILM DELLA CRISI DI IMPRESA" del prof. Fabiani su questa rivista. Con questa lettura possiamo meglio interpretare la sceneggiatura della crisi che può vedere il singolo professionista vestire i panni di Advisor in un procedimento, di Attestatore in altro e di Esperto in altro ancora. Forse il grande interprete deve sapersi calare nelle diverse parti abbandonando ogni preconcetto, ogni ragionamento apodittico (lo dico anche a me stesso, of course).
10 Ottobre 2025 9:13
La mia risposta partirà proprio da questo dato e da quello che indica al 2% (6 miliardi, il fabbisogno minimo ulteriore della sanità pubblica) il tasso di escussione.
Nell’articolo non v’è traccia di rinunce al regresso da parte degli enti statali garanti, che sarebbero antinomiche rispetto alla preoccupata attenzione del Governo al tema.
Chiudo questo primo flash introduttivo segnando che a guidare le nostre strategie di “risanatori” non dovrebbe essere il perseguimento di un obiettivo “insicuro”, incerto nella sua realizzabilità, bensì il perseguimento di obiettivi ragionevoli. Nel senso che se l’esistenza di chance di risanamento devono essere ragionevoli, gli obiettivi dovrebbero essere “sicuri”.
Non aggiungo altro per non privare di organicità la mia replica che spero di chiudere nel we.
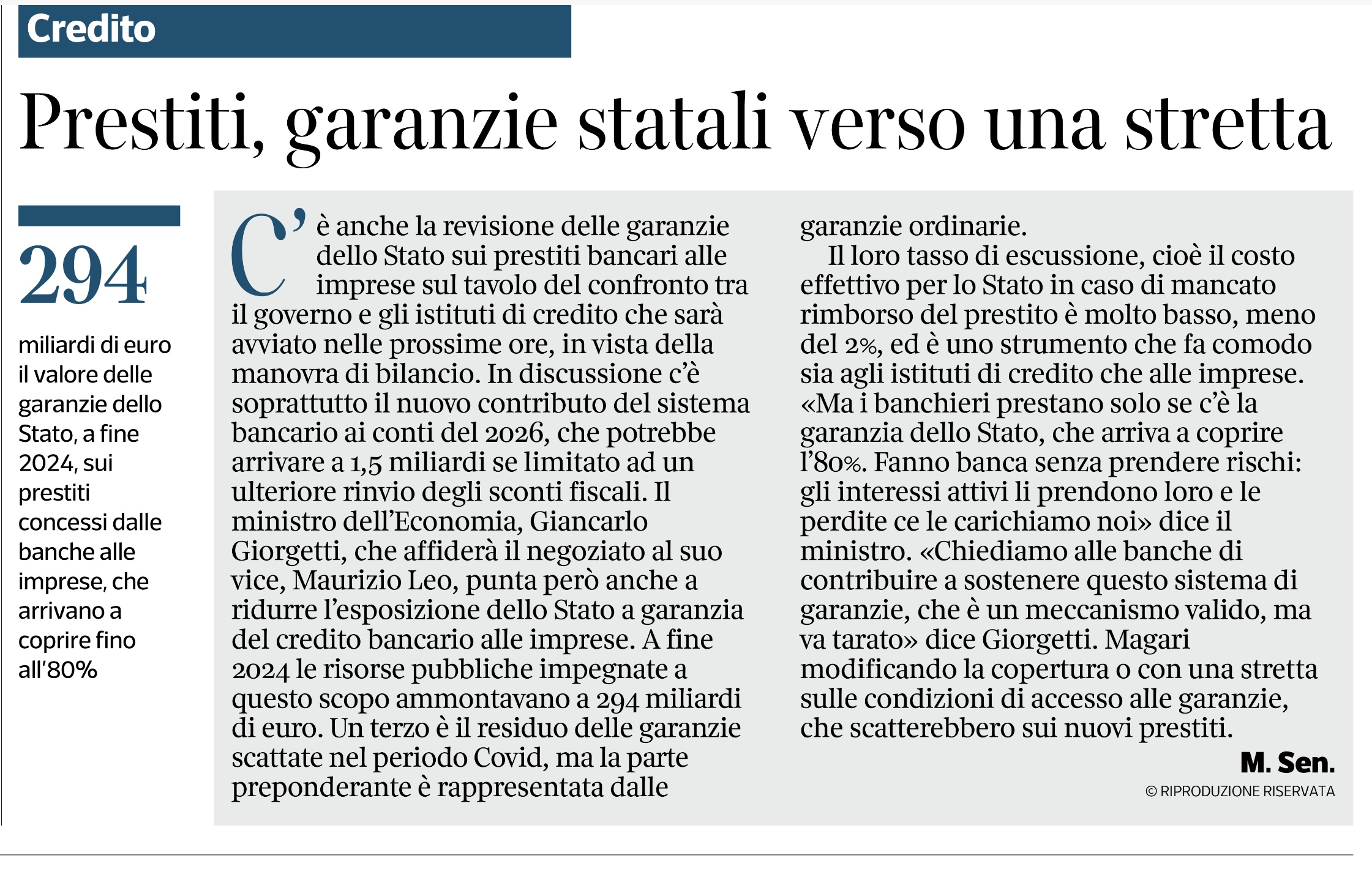
11 Ottobre 2025 10:39
La mia risposta partirà proprio da questo dato e da quello che indica al 2% (6 miliardi, il fabbisogno minimo ulteriore della sanità pubblica) il tasso di escussione.
Nell’articolo non v’è traccia di rinunce al regresso da parte degli enti statali garanti, che sarebbero antinomiche rispetto alla preoccupata attenzione del Governo al tema.
Chiudo questo primo flash introduttivo segnando che a guidare le nostre strategie di “risanatori” non dovrebbe essere il perseguimento di un obiettivo “insicuro”, incerto nella sua realizzabilità, bensì il perseguimento di obiettivi ragionevoli. Nel senso che se l’esistenza di chance di risanamento devono essere ragionevoli, gli obiettivi dovrebbero essere “sicuri”.
Non aggiungo altro per non privare di organicità la mia replica che spero di chiudere nel we.
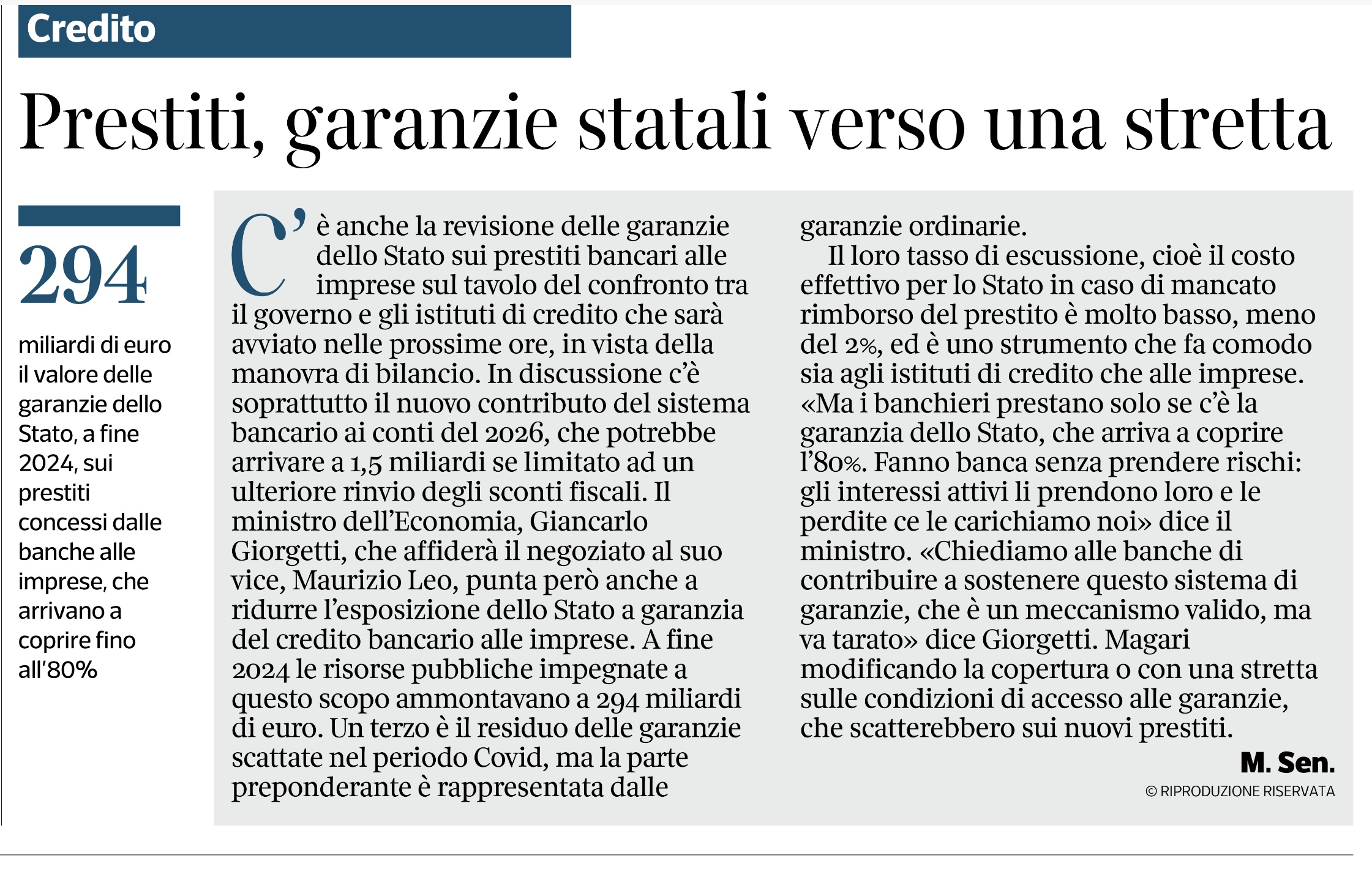
- Decreto ministeriale 2 agosto 2023 Ministero delle Imprese e del Made in Italy- Fondo di Garanzia. Approvazione modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale
- Circolare n. 9/2024 Medio Credito CentraleProlungamenti della durata della garanzia per temporanea difficoltà dell'impresa, ai sensi della Parte VI, paragrafo D delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, per le operazioni ammesse ai sensi della Sezione 2.2 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (di seguito "Temporary Crisis and Transition Framework" o "TCTF")
Ove documenti non rinvenuti sul sito ufficiale di MCC, possono trovarsi su I Codici della Concorsualita’ - App. 14 .
11 Ottobre 2025 20:54
- Decreto ministeriale 2 agosto 2023 Ministero delle Imprese e del Made in Italy- Fondo di Garanzia. Approvazione modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale
- Circolare n. 9/2024 Medio Credito CentraleProlungamenti della durata della garanzia per temporanea difficoltà dell'impresa, ai sensi della Parte VI, paragrafo D delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, per le operazioni ammesse ai sensi della Sezione 2.2 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (di seguito "Temporary Crisis and Transition Framework" o "TCTF")
Ove documenti non rinvenuti sul sito ufficiale di MCC, possono trovarsi su I Codici della Concorsualita’ - App. 14 .
Se sì, provvederei io stesso a notificare la violazione delle norme sugli aiuti di Stato alla Commissione UE.
12 Ottobre 2025 18:32
- Decreto ministeriale 2 agosto 2023 Ministero delle Imprese e del Made in Italy- Fondo di Garanzia. Approvazione modifiche e integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale
- Circolare n. 9/2024 Medio Credito CentraleProlungamenti della durata della garanzia per temporanea difficoltà dell'impresa, ai sensi della Parte VI, paragrafo D delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, per le operazioni ammesse ai sensi della Sezione 2.2 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (di seguito "Temporary Crisis and Transition Framework" o "TCTF")
Ove documenti non rinvenuti sul sito ufficiale di MCC, possono trovarsi su I Codici della Concorsualita’ - App. 14 .
Premessa
Provo a replicare alle diverse critiche ed eccezioni che sono state formulate al mio intervento iniziale, non senza aver prima sgombrato il campo da un equivoco: non ho mai sostenuto che MCC o Sace non potessero transigere i loro crediti di regresso super privilegiati. Mi ero già espresso in modo chiaro nella risposta data al collega Carlo Pirozzi. Né poteva essere diversamente, avendo speso fiumi d’inchiostro sulla transigibilità dell’IVA. Infatti, mi si può rimproverare tutto, ma non di non essere testardamente coerente.
La cornice normativa e la sua ratio
Le disposizioni sui finanziamenti garantiti dallo Stato sono state così ricostruite dalla Corte di cassazione con la sentenza 10 aprile 2024, n. 9657:
Dunque, secondo la ricostruzione del giudice di legittimità, la surrogazione è stata concepita dal legislatore come mezzo per recuperare al bilancio statale risorse pubbliche originariamente impegnate in interventi di sostegno pubblico all’economia.
Giova, allora, ricordare che costituisce aiuto di Stato qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza.
La previsione della surroga, quindi, accompagnata da un diritto di prelazione quasi assoluto risponde(va), proprio alla necessità evitare ogni contestazione in tal senso da parte della Commissione UE. Se così è, predicare la legittimità della rinuncia al diritto di surroga da parte dell’ente statale non può non apparire una pericolosa fuga in avanti che porterebbe la norma, così applicata in concreto, sotto la lente UE.
Né può autorizzare una simile declinazione la struttura irrazionale della disposizione da me denunciata nell’avvio del blog.
Analogamente pericoloso sarebbe forzarne la ratio, poiché non sarebbe la prima volta che la condanna da parte della Corte di Giustizia UE perviene a seguito della contestazione di un uso del pubblico incentivo in modo difforme rispetto alle disposizioni normative che lo avevano introdotto.
Dal momento che tale attesa sarebbe quanto meno dubbia, penso anche che quel professionista avveduto darà conto, pure, delle ragioni per cui l’ente pubblico garante abbia interesse a rinunciare alla surroga.
Non solo, il piano darà anche conto di come ottenere, nell’ambito delle trattative della Composizione negoziata, tale rinunzia.
Ed allora dovrebbe confrontarsi con lo scenario alternativo, spiegando perché in caso di sottomissione dell’impresa alla LG il garante pubblico resterebbe con un “mucchio di mosche in mano” nonostante il suo credito sia assistito da un “super” privilegio generale.
Da questo punto di vista, non è possibile escludere che al di fuori dell’id plerumque accidit si possa verificare che il secondo privilegio generale non sia soddisfatto nell’ambito di una LG, ma non è possibile legittimare una linea di condotta generale sulla base di un’eccezione.
Dunque, lato ente pubblico garante occorrerebbe che, ove escusso per l’intero 80%, esso non possa recuperare dalla LG neppure un solo euro in più di quanto il piano prevede di destinare alla banca garantita in qualità di creditore chirografario, considerando che nella ipotetica LG il soddisfacimento degli altri creditori chirografi sarebbe postergato al proprio credito di regresso.
Ciò potrebbe essere obiettivamente possibile in astratto, ma, anche in tale residuale ipotesi, si dovrebbe tenere conto di una ulteriore circostanza: ossia che alla medesima ristrutturazione potrebbe pervenirsi per il tramite di un concordato preventivo, dove la ricchezza dovrebbe essere distribuita secondo il doppio meccanismo della priorità assoluta sul “valore di liquidazione” e della priorità relativa sul “valore eccedente.
Col che il compito del consulente dell’impresa in crisi – se avveduto - si complicherebbe ulteriormente non poco. Stante la collocazione prioritaria del credito di regresso lo Stato garante avrebbe, infatti, interesse – anche a sollievo delle responsabilità dei propri funzionari – che la distribuzione delle risorse avvenisse sotto l’occhiuto controllo del tribunale e non del solo esperto, con cui, per altro, non avrebbe mai neppure parlato . Non va dimenticato in proposito che, contrariamente a quanto accade per i tributi – che hanno un grado di protezione inferiore -, la rinuncia al diritto di regresso non troverebbe conforto in nessun tipo di attestazione terza di convenienza.
Possiamo ora passare alla seconda questione, ossia come prevedere, nel piano, di ottenere il consenso del garante pubblico.
Mi par di capire – ma posso aver male interpretato – che del consenso del garante se ne dovrebbe occupare la banca garantita, dato che si è affermato che il garante non può essere chiamato al tavolo delle trattative, o, comunque, avrebbe diritto a non parteciparvi, se non previamente escusso. E di escussione non se ne vuol sentir parlare. Qui si aprono questioni estremamente delicate.
Da un lato ci si verrebbe a trovare difronte a un piano la cui ragionevole perseguibilità dipenderebbe dalla rinuncia alla surroga da parte del garante pubblico, senza che la rinuncia sia oggetto di trattativa nell’ambito della Composizione negoziata. Un’antinomia insuperabile, almeno a mio parere, poiché eversiva della stessa natura della CN, che pretende un negoziato trasparente, condotto secondo principi di buona fede e correttezza, sotto la regia dell’esperto.
Dall’altro, quest’ultimo sarebbe privato degli strumenti necessari a valutare se, lato garante pubblico, si siano fatti, o no, progressi verso la condivisione del piano che, rammentiamoci, prevederebbe una rinuncia totale al credito di regresso. L’esperto dovrebbe fidarsi delle percezioni de relato della banca garantita, ma, sempre a mio parere, ove si affidasse al racconto di un terzo violerebbe gravemente il proprio mandato.
Quanto sino a questo momento argomentato mi porta a ritenere che un piano di ristrutturazione che fondi le sue possibilità di successo su un’attesa rinuncia di un creditore eventuale che non partecipa alle trattative della CN sia un piano quanto mai “ballerino”.
A mio parere, quindi, sarebbe in ogni caso preclusa ogni possibilità di ricorrere al concordato semplificato per assenza di buona fede nelle trattative.
Non solo. Se fossi il curatore della successiva dichiarata LG svolgerei nei confronti del professionista e dell’esperto quantomeno l’eccezione di inadempimento e, ove ne ricorressero le condizioni, ipotizzerei a loro carico, nella relazione ex art. 130 CCII, anche il concorso in bancarotta, se non altro di carattere preferenziale per i pagamenti effettuati in favore di creditori chirografari in presenza di un rischio concreto del possibile insorgere di un credito statale super privilegiato, lasciando in disparte eventuali super compensi percepiti dal consulente.
Prima di affrontare temi “mercatistici”, fossi io il “ristrutturatore” di turno, pondererei, quindi, con grande prudenza il confezionamento di un piano che prevedesse contemporaneamente la rinuncia al regresso dell’ente pubblico garante e la sua non partecipazione al tavolo delle trattative della CN.
La banca garantita all’80% non ha particolare interesse – salvo nell’ipotesi di una proposta di soddisfacimento almeno pari a tale percentuale, con pagamento, per altro, illico te immediate – ad accettare trattamenti inferiori e, per di più rateizzati, e promettere, al contempo, di ottenere la rinuncia al regresso del garante.
Escutere la garanzia sarebbe, al contrario, il comportamento più naturale secondo le prassi di mercato.
Di contro per MCC/Sace il regresso assistito dal super privilegio costituirebbe la condotta mercatistica tipica.
Al contrario si pretende che un piano di risanamento possa fondare la sua ragionevolezza sull’assunzione che dei soggetti economici professionali – lasciando in totale disparte gli eventuali obblighi giuridici che incombono su di loro – agiscano al di fuori delle regole di mercato, facendo recedere i loro interessi adeguatamente tutelati dalla legge difronte a quelli dell’impresa in crisi.
Occorre, dunque, che si spieghino le ragioni perché ciò possa ragionevolmente accadere.
Siamo al solito: “il salvataggio dell’impresa in crisi è bene in sé” e prevale su ogni altro “bene della vita” o interesse economico, che, al suo cospetto, devono recedere anche in una posizione più deteriore rispetto a quella che le regole del concorso gli attribuirebbero, ove il concorso si aprisse.
Come, però, ho più volte sostenuto, se nell’ambito degli strumenti giudiziali per il superamento della crisi possono ravvisarsi norme (che a me non piacciono) che legittimano l’affermazione che il salvataggio dell’impresa costituisce un valore superiore, è indubbio come tale super-valore trovi dei limiti insuperabili nelle disposizioni che regolano quegli istituti.
Ne consegue che lo stesso non può dirsi riguardo alla CN dove sono assenti regole di concorso e dove ciascun creditore ha solo l’obbligo di partecipare alle trattative secondo principi di buona fede e correttezza, ma non di aderire alle proposte del proprio debitore, se non perché le giudica conformi ai propri migliori interessi rispetto a quella concreta situazione.
Il primo dato che colpisce è l’entità, in valore assoluto, delle escussioni: 6 miliardi, a cui si deve aggiungere un altro 1 miliardo e spiccioli perso dalle banche, trasferiti a imprese che nell’arco di un quinquennio sono finite in default.
Da questi dati emerge che ove gli enti garanti rinunciassero al regresso si consoliderebbe un intervento a sostegno di imprese, poi “fallite”, di entità tale da non poter non essere considerato un aiuto di Stato, con l’aggravante che così ingenti risorse pubbliche, diversamente destinabili alla sanità pubblica, sarebbero state assegnate a imprese che, con ogni probabilità, si trovavano in difficoltà già al momento dell’ottenimento del finanziamento assistito dalla garanzia statale.
Ecco perché ipotizzare che il garante pubblico rinunci al diritto di regresso verso l’impresa in CN verrebbe a costituire una seconda violazione del divieto agli aiuti di Stato.
Ed ancora, dall’articolo del Corriere della Sera emerge anche della volontà del governo di porre un freno al rilascio delle pubbliche garanzie a sostegno delle imprese, sicché ipotizzare, in un quadro di revisione dello strumento stesso, che lo Stato rinunci al diritto di regresso assistito dal super privilegio, sarebbe ulteriormente assai imprudente.
🔶 🔶 🔶
A voi la parola, dunque…
13 Ottobre 2025 9:12
Premessa
Provo a replicare alle diverse critiche ed eccezioni che sono state formulate al mio intervento iniziale, non senza aver prima sgombrato il campo da un equivoco: non ho mai sostenuto che MCC o Sace non potessero transigere i loro crediti di regresso super privilegiati. Mi ero già espresso in modo chiaro nella risposta data al collega Carlo Pirozzi. Né poteva essere diversamente, avendo speso fiumi d’inchiostro sulla transigibilità dell’IVA. Infatti, mi si può rimproverare tutto, ma non di non essere testardamente coerente.
La cornice normativa e la sua ratio
Le disposizioni sui finanziamenti garantiti dallo Stato sono state così ricostruite dalla Corte di cassazione con la sentenza 10 aprile 2024, n. 9657:
Dunque, secondo la ricostruzione del giudice di legittimità, la surrogazione è stata concepita dal legislatore come mezzo per recuperare al bilancio statale risorse pubbliche originariamente impegnate in interventi di sostegno pubblico all’economia.
Giova, allora, ricordare che costituisce aiuto di Stato qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza.
La previsione della surroga, quindi, accompagnata da un diritto di prelazione quasi assoluto risponde(va), proprio alla necessità evitare ogni contestazione in tal senso da parte della Commissione UE. Se così è, predicare la legittimità della rinuncia al diritto di surroga da parte dell’ente statale non può non apparire una pericolosa fuga in avanti che porterebbe la norma, così applicata in concreto, sotto la lente UE.
Né può autorizzare una simile declinazione la struttura irrazionale della disposizione da me denunciata nell’avvio del blog.
Analogamente pericoloso sarebbe forzarne la ratio, poiché non sarebbe la prima volta che la condanna da parte della Corte di Giustizia UE perviene a seguito della contestazione di un uso del pubblico incentivo in modo difforme rispetto alle disposizioni normative che lo avevano introdotto.
Dal momento che tale attesa sarebbe quanto meno dubbia, penso anche che quel professionista avveduto darà conto, pure, delle ragioni per cui l’ente pubblico garante abbia interesse a rinunciare alla surroga.
Non solo, il piano darà anche conto di come ottenere, nell’ambito delle trattative della Composizione negoziata, tale rinunzia.
Ed allora dovrebbe confrontarsi con lo scenario alternativo, spiegando perché in caso di sottomissione dell’impresa alla LG il garante pubblico resterebbe con un “mucchio di mosche in mano” nonostante il suo credito sia assistito da un “super” privilegio generale.
Da questo punto di vista, non è possibile escludere che al di fuori dell’id plerumque accidit si possa verificare che il secondo privilegio generale non sia soddisfatto nell’ambito di una LG, ma non è possibile legittimare una linea di condotta generale sulla base di un’eccezione.
Dunque, lato ente pubblico garante occorrerebbe che, ove escusso per l’intero 80%, esso non possa recuperare dalla LG neppure un solo euro in più di quanto il piano prevede di destinare alla banca garantita in qualità di creditore chirografario, considerando che nella ipotetica LG il soddisfacimento degli altri creditori chirografi sarebbe postergato al proprio credito di regresso.
Ciò potrebbe essere obiettivamente possibile in astratto, ma, anche in tale residuale ipotesi, si dovrebbe tenere conto di una ulteriore circostanza: ossia che alla medesima ristrutturazione potrebbe pervenirsi per il tramite di un concordato preventivo, dove la ricchezza dovrebbe essere distribuita secondo il doppio meccanismo della priorità assoluta sul “valore di liquidazione” e della priorità relativa sul “valore eccedente.
Col che il compito del consulente dell’impresa in crisi – se avveduto - si complicherebbe ulteriormente non poco. Stante la collocazione prioritaria del credito di regresso lo Stato garante avrebbe, infatti, interesse – anche a sollievo delle responsabilità dei propri funzionari – che la distribuzione delle risorse avvenisse sotto l’occhiuto controllo del tribunale e non del solo esperto, con cui, per altro, non avrebbe mai neppure parlato . Non va dimenticato in proposito che, contrariamente a quanto accade per i tributi – che hanno un grado di protezione inferiore -, la rinuncia al diritto di regresso non troverebbe conforto in nessun tipo di attestazione terza di convenienza.
Possiamo ora passare alla seconda questione, ossia come prevedere, nel piano, di ottenere il consenso del garante pubblico.
Mi par di capire – ma posso aver male interpretato – che del consenso del garante se ne dovrebbe occupare la banca garantita, dato che si è affermato che il garante non può essere chiamato al tavolo delle trattative, o, comunque, avrebbe diritto a non parteciparvi, se non previamente escusso. E di escussione non se ne vuol sentir parlare. Qui si aprono questioni estremamente delicate.
Da un lato ci si verrebbe a trovare difronte a un piano la cui ragionevole perseguibilità dipenderebbe dalla rinuncia alla surroga da parte del garante pubblico, senza che la rinuncia sia oggetto di trattativa nell’ambito della Composizione negoziata. Un’antinomia insuperabile, almeno a mio parere, poiché eversiva della stessa natura della CN, che pretende un negoziato trasparente, condotto secondo principi di buona fede e correttezza, sotto la regia dell’esperto.
Dall’altro, quest’ultimo sarebbe privato degli strumenti necessari a valutare se, lato garante pubblico, si siano fatti, o no, progressi verso la condivisione del piano che, rammentiamoci, prevederebbe una rinuncia totale al credito di regresso. L’esperto dovrebbe fidarsi delle percezioni de relato della banca garantita, ma, sempre a mio parere, ove si affidasse al racconto di un terzo violerebbe gravemente il proprio mandato.
Quanto sino a questo momento argomentato mi porta a ritenere che un piano di ristrutturazione che fondi le sue possibilità di successo su un’attesa rinuncia di un creditore eventuale che non partecipa alle trattative della CN sia un piano quanto mai “ballerino”.
A mio parere, quindi, sarebbe in ogni caso preclusa ogni possibilità di ricorrere al concordato semplificato per assenza di buona fede nelle trattative.
Non solo. Se fossi il curatore della successiva dichiarata LG svolgerei nei confronti del professionista e dell’esperto quantomeno l’eccezione di inadempimento e, ove ne ricorressero le condizioni, ipotizzerei a loro carico, nella relazione ex art. 130 CCII, anche il concorso in bancarotta, se non altro di carattere preferenziale per i pagamenti effettuati in favore di creditori chirografari in presenza di un rischio concreto del possibile insorgere di un credito statale super privilegiato, lasciando in disparte eventuali super compensi percepiti dal consulente.
Prima di affrontare temi “mercatistici”, fossi io il “ristrutturatore” di turno, pondererei, quindi, con grande prudenza il confezionamento di un piano che prevedesse contemporaneamente la rinuncia al regresso dell’ente pubblico garante e la sua non partecipazione al tavolo delle trattative della CN.
La banca garantita all’80% non ha particolare interesse – salvo nell’ipotesi di una proposta di soddisfacimento almeno pari a tale percentuale, con pagamento, per altro, illico te immediate – ad accettare trattamenti inferiori e, per di più rateizzati, e promettere, al contempo, di ottenere la rinuncia al regresso del garante.
Escutere la garanzia sarebbe, al contrario, il comportamento più naturale secondo le prassi di mercato.
Di contro per MCC/Sace il regresso assistito dal super privilegio costituirebbe la condotta mercatistica tipica.
Al contrario si pretende che un piano di risanamento possa fondare la sua ragionevolezza sull’assunzione che dei soggetti economici professionali – lasciando in totale disparte gli eventuali obblighi giuridici che incombono su di loro – agiscano al di fuori delle regole di mercato, facendo recedere i loro interessi adeguatamente tutelati dalla legge difronte a quelli dell’impresa in crisi.
Occorre, dunque, che si spieghino le ragioni perché ciò possa ragionevolmente accadere.
Siamo al solito: “il salvataggio dell’impresa in crisi è bene in sé” e prevale su ogni altro “bene della vita” o interesse economico, che, al suo cospetto, devono recedere anche in una posizione più deteriore rispetto a quella che le regole del concorso gli attribuirebbero, ove il concorso si aprisse.
Come, però, ho più volte sostenuto, se nell’ambito degli strumenti giudiziali per il superamento della crisi possono ravvisarsi norme (che a me non piacciono) che legittimano l’affermazione che il salvataggio dell’impresa costituisce un valore superiore, è indubbio come tale super-valore trovi dei limiti insuperabili nelle disposizioni che regolano quegli istituti.
Ne consegue che lo stesso non può dirsi riguardo alla CN dove sono assenti regole di concorso e dove ciascun creditore ha solo l’obbligo di partecipare alle trattative secondo principi di buona fede e correttezza, ma non di aderire alle proposte del proprio debitore, se non perché le giudica conformi ai propri migliori interessi rispetto a quella concreta situazione.
Il primo dato che colpisce è l’entità, in valore assoluto, delle escussioni: 6 miliardi, a cui si deve aggiungere un altro 1 miliardo e spiccioli perso dalle banche, trasferiti a imprese che nell’arco di un quinquennio sono finite in default.
Da questi dati emerge che ove gli enti garanti rinunciassero al regresso si consoliderebbe un intervento a sostegno di imprese, poi “fallite”, di entità tale da non poter non essere considerato un aiuto di Stato, con l’aggravante che così ingenti risorse pubbliche, diversamente destinabili alla sanità pubblica, sarebbero state assegnate a imprese che, con ogni probabilità, si trovavano in difficoltà già al momento dell’ottenimento del finanziamento assistito dalla garanzia statale.
Ecco perché ipotizzare che il garante pubblico rinunci al diritto di regresso verso l’impresa in CN verrebbe a costituire una seconda violazione del divieto agli aiuti di Stato.
Ed ancora, dall’articolo del Corriere della Sera emerge anche della volontà del governo di porre un freno al rilascio delle pubbliche garanzie a sostegno delle imprese, sicché ipotizzare, in un quadro di revisione dello strumento stesso, che lo Stato rinunci al diritto di regresso assistito dal super privilegio, sarebbe ulteriormente assai imprudente.
🔶 🔶 🔶
A voi la parola, dunque…
once again, you got the point.
Cari saluti.
Edoardo
13 Ottobre 2025 10:45
Premessa
Provo a replicare alle diverse critiche ed eccezioni che sono state formulate al mio intervento iniziale, non senza aver prima sgombrato il campo da un equivoco: non ho mai sostenuto che MCC o Sace non potessero transigere i loro crediti di regresso super privilegiati. Mi ero già espresso in modo chiaro nella risposta data al collega Carlo Pirozzi. Né poteva essere diversamente, avendo speso fiumi d’inchiostro sulla transigibilità dell’IVA. Infatti, mi si può rimproverare tutto, ma non di non essere testardamente coerente.
La cornice normativa e la sua ratio
Le disposizioni sui finanziamenti garantiti dallo Stato sono state così ricostruite dalla Corte di cassazione con la sentenza 10 aprile 2024, n. 9657:
Dunque, secondo la ricostruzione del giudice di legittimità, la surrogazione è stata concepita dal legislatore come mezzo per recuperare al bilancio statale risorse pubbliche originariamente impegnate in interventi di sostegno pubblico all’economia.
Giova, allora, ricordare che costituisce aiuto di Stato qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza.
La previsione della surroga, quindi, accompagnata da un diritto di prelazione quasi assoluto risponde(va), proprio alla necessità evitare ogni contestazione in tal senso da parte della Commissione UE. Se così è, predicare la legittimità della rinuncia al diritto di surroga da parte dell’ente statale non può non apparire una pericolosa fuga in avanti che porterebbe la norma, così applicata in concreto, sotto la lente UE.
Né può autorizzare una simile declinazione la struttura irrazionale della disposizione da me denunciata nell’avvio del blog.
Analogamente pericoloso sarebbe forzarne la ratio, poiché non sarebbe la prima volta che la condanna da parte della Corte di Giustizia UE perviene a seguito della contestazione di un uso del pubblico incentivo in modo difforme rispetto alle disposizioni normative che lo avevano introdotto.
Dal momento che tale attesa sarebbe quanto meno dubbia, penso anche che quel professionista avveduto darà conto, pure, delle ragioni per cui l’ente pubblico garante abbia interesse a rinunciare alla surroga.
Non solo, il piano darà anche conto di come ottenere, nell’ambito delle trattative della Composizione negoziata, tale rinunzia.
Ed allora dovrebbe confrontarsi con lo scenario alternativo, spiegando perché in caso di sottomissione dell’impresa alla LG il garante pubblico resterebbe con un “mucchio di mosche in mano” nonostante il suo credito sia assistito da un “super” privilegio generale.
Da questo punto di vista, non è possibile escludere che al di fuori dell’id plerumque accidit si possa verificare che il secondo privilegio generale non sia soddisfatto nell’ambito di una LG, ma non è possibile legittimare una linea di condotta generale sulla base di un’eccezione.
Dunque, lato ente pubblico garante occorrerebbe che, ove escusso per l’intero 80%, esso non possa recuperare dalla LG neppure un solo euro in più di quanto il piano prevede di destinare alla banca garantita in qualità di creditore chirografario, considerando che nella ipotetica LG il soddisfacimento degli altri creditori chirografi sarebbe postergato al proprio credito di regresso.
Ciò potrebbe essere obiettivamente possibile in astratto, ma, anche in tale residuale ipotesi, si dovrebbe tenere conto di una ulteriore circostanza: ossia che alla medesima ristrutturazione potrebbe pervenirsi per il tramite di un concordato preventivo, dove la ricchezza dovrebbe essere distribuita secondo il doppio meccanismo della priorità assoluta sul “valore di liquidazione” e della priorità relativa sul “valore eccedente.
Col che il compito del consulente dell’impresa in crisi – se avveduto - si complicherebbe ulteriormente non poco. Stante la collocazione prioritaria del credito di regresso lo Stato garante avrebbe, infatti, interesse – anche a sollievo delle responsabilità dei propri funzionari – che la distribuzione delle risorse avvenisse sotto l’occhiuto controllo del tribunale e non del solo esperto, con cui, per altro, non avrebbe mai neppure parlato . Non va dimenticato in proposito che, contrariamente a quanto accade per i tributi – che hanno un grado di protezione inferiore -, la rinuncia al diritto di regresso non troverebbe conforto in nessun tipo di attestazione terza di convenienza.
Possiamo ora passare alla seconda questione, ossia come prevedere, nel piano, di ottenere il consenso del garante pubblico.
Mi par di capire – ma posso aver male interpretato – che del consenso del garante se ne dovrebbe occupare la banca garantita, dato che si è affermato che il garante non può essere chiamato al tavolo delle trattative, o, comunque, avrebbe diritto a non parteciparvi, se non previamente escusso. E di escussione non se ne vuol sentir parlare. Qui si aprono questioni estremamente delicate.
Da un lato ci si verrebbe a trovare difronte a un piano la cui ragionevole perseguibilità dipenderebbe dalla rinuncia alla surroga da parte del garante pubblico, senza che la rinuncia sia oggetto di trattativa nell’ambito della Composizione negoziata. Un’antinomia insuperabile, almeno a mio parere, poiché eversiva della stessa natura della CN, che pretende un negoziato trasparente, condotto secondo principi di buona fede e correttezza, sotto la regia dell’esperto.
Dall’altro, quest’ultimo sarebbe privato degli strumenti necessari a valutare se, lato garante pubblico, si siano fatti, o no, progressi verso la condivisione del piano che, rammentiamoci, prevederebbe una rinuncia totale al credito di regresso. L’esperto dovrebbe fidarsi delle percezioni de relato della banca garantita, ma, sempre a mio parere, ove si affidasse al racconto di un terzo violerebbe gravemente il proprio mandato.
Quanto sino a questo momento argomentato mi porta a ritenere che un piano di ristrutturazione che fondi le sue possibilità di successo su un’attesa rinuncia di un creditore eventuale che non partecipa alle trattative della CN sia un piano quanto mai “ballerino”.
A mio parere, quindi, sarebbe in ogni caso preclusa ogni possibilità di ricorrere al concordato semplificato per assenza di buona fede nelle trattative.
Non solo. Se fossi il curatore della successiva dichiarata LG svolgerei nei confronti del professionista e dell’esperto quantomeno l’eccezione di inadempimento e, ove ne ricorressero le condizioni, ipotizzerei a loro carico, nella relazione ex art. 130 CCII, anche il concorso in bancarotta, se non altro di carattere preferenziale per i pagamenti effettuati in favore di creditori chirografari in presenza di un rischio concreto del possibile insorgere di un credito statale super privilegiato, lasciando in disparte eventuali super compensi percepiti dal consulente.
Prima di affrontare temi “mercatistici”, fossi io il “ristrutturatore” di turno, pondererei, quindi, con grande prudenza il confezionamento di un piano che prevedesse contemporaneamente la rinuncia al regresso dell’ente pubblico garante e la sua non partecipazione al tavolo delle trattative della CN.
La banca garantita all’80% non ha particolare interesse – salvo nell’ipotesi di una proposta di soddisfacimento almeno pari a tale percentuale, con pagamento, per altro, illico te immediate – ad accettare trattamenti inferiori e, per di più rateizzati, e promettere, al contempo, di ottenere la rinuncia al regresso del garante.
Escutere la garanzia sarebbe, al contrario, il comportamento più naturale secondo le prassi di mercato.
Di contro per MCC/Sace il regresso assistito dal super privilegio costituirebbe la condotta mercatistica tipica.
Al contrario si pretende che un piano di risanamento possa fondare la sua ragionevolezza sull’assunzione che dei soggetti economici professionali – lasciando in totale disparte gli eventuali obblighi giuridici che incombono su di loro – agiscano al di fuori delle regole di mercato, facendo recedere i loro interessi adeguatamente tutelati dalla legge difronte a quelli dell’impresa in crisi.
Occorre, dunque, che si spieghino le ragioni perché ciò possa ragionevolmente accadere.
Siamo al solito: “il salvataggio dell’impresa in crisi è bene in sé” e prevale su ogni altro “bene della vita” o interesse economico, che, al suo cospetto, devono recedere anche in una posizione più deteriore rispetto a quella che le regole del concorso gli attribuirebbero, ove il concorso si aprisse.
Come, però, ho più volte sostenuto, se nell’ambito degli strumenti giudiziali per il superamento della crisi possono ravvisarsi norme (che a me non piacciono) che legittimano l’affermazione che il salvataggio dell’impresa costituisce un valore superiore, è indubbio come tale super-valore trovi dei limiti insuperabili nelle disposizioni che regolano quegli istituti.
Ne consegue che lo stesso non può dirsi riguardo alla CN dove sono assenti regole di concorso e dove ciascun creditore ha solo l’obbligo di partecipare alle trattative secondo principi di buona fede e correttezza, ma non di aderire alle proposte del proprio debitore, se non perché le giudica conformi ai propri migliori interessi rispetto a quella concreta situazione.
Il primo dato che colpisce è l’entità, in valore assoluto, delle escussioni: 6 miliardi, a cui si deve aggiungere un altro 1 miliardo e spiccioli perso dalle banche, trasferiti a imprese che nell’arco di un quinquennio sono finite in default.
Da questi dati emerge che ove gli enti garanti rinunciassero al regresso si consoliderebbe un intervento a sostegno di imprese, poi “fallite”, di entità tale da non poter non essere considerato un aiuto di Stato, con l’aggravante che così ingenti risorse pubbliche, diversamente destinabili alla sanità pubblica, sarebbero state assegnate a imprese che, con ogni probabilità, si trovavano in difficoltà già al momento dell’ottenimento del finanziamento assistito dalla garanzia statale.
Ecco perché ipotizzare che il garante pubblico rinunci al diritto di regresso verso l’impresa in CN verrebbe a costituire una seconda violazione del divieto agli aiuti di Stato.
Ed ancora, dall’articolo del Corriere della Sera emerge anche della volontà del governo di porre un freno al rilascio delle pubbliche garanzie a sostegno delle imprese, sicché ipotizzare, in un quadro di revisione dello strumento stesso, che lo Stato rinunci al diritto di regresso assistito dal super privilegio, sarebbe ulteriormente assai imprudente.
🔶 🔶 🔶
A voi la parola, dunque…
13 Ottobre 2025 18:08
In verità, la ratio è stata chiarita da plurime sentenze di Cassazione, che ho provato ad illustrare qui https://www.dirittodelrisparmio.it/2023/02/12/e-olivieri-nel-recupero-del-credito-privilegiato-il-fondo-di-garanzia-per-le-pmi-si-surroga-oppure-no/
C'è da dire (a mio personale avviso) che tutto muove da una considerazione perfettibile. Non errata, ma perfettibile. Che è quella di considerare l'intervento del Fondo (e di SACE) esclusivamente come una mera garanzia sul credito e non è così semplice. In realtà bisognerebbe considerare che si tratta, prima di ogni altra cosa, di un'agevolazione di Stato soggetta alle limitazioni delle normative unionali sugli Aiuti di Stato.
Se uno tiene la barra dritta su questo punto, si spiegano molte cose, anche se continuano a non essere chiare (ed equivocate) molte altre. E qui parlo esplicitamente del Fondo, non di SACE.
Tra queste, le richieste di inibitoria a causa del fatto che è difficile condurre gli enti garanti al tavolo delle trattative. Non c'è alcun bisogno (a mio modesto parere) di provvedimenti cautelari inibitori, che andrebbero tutti respinti e non accolti, se si conoscessero bene (al di là del fatto che uno possa condividerle o meno ed io "non" le condivido, almeno per come sono materialmente scritte) le disposizioni del Fondo. Per quanto riguarda SACE, invece, comanda il contratto di garanzia, che è cosa ben diversa dalle disposizioni del Fondo.
13 Ottobre 2025 21:41
In verità, la ratio è stata chiarita da plurime sentenze di Cassazione, che ho provato ad illustrare qui https://www.dirittodelrisparmio.it/2023/02/12/e-olivieri-nel-recupero-del-credito-privilegiato-il-fondo-di-garanzia-per-le-pmi-si-surroga-oppure-no/
C'è da dire (a mio personale avviso) che tutto muove da una considerazione perfettibile. Non errata, ma perfettibile. Che è quella di considerare l'intervento del Fondo (e di SACE) esclusivamente come una mera garanzia sul credito e non è così semplice. In realtà bisognerebbe considerare che si tratta, prima di ogni altra cosa, di un'agevolazione di Stato soggetta alle limitazioni delle normative unionali sugli Aiuti di Stato.
Se uno tiene la barra dritta su questo punto, si spiegano molte cose, anche se continuano a non essere chiare (ed equivocate) molte altre. E qui parlo esplicitamente del Fondo, non di SACE.
Tra queste, le richieste di inibitoria a causa del fatto che è difficile condurre gli enti garanti al tavolo delle trattative. Non c'è alcun bisogno (a mio modesto parere) di provvedimenti cautelari inibitori, che andrebbero tutti respinti e non accolti, se si conoscessero bene (al di là del fatto che uno possa condividerle o meno ed io "non" le condivido, almeno per come sono materialmente scritte) le disposizioni del Fondo. Per quanto riguarda SACE, invece, comanda il contratto di garanzia, che è cosa ben diversa dalle disposizioni del Fondo.
«La ratio di questo miracoloso arabesco giuridico non è mai stata chiarita, dato che – per chi è dotato di un minimo di razionalità – o il prestito garantito è rimborsato integralmente, e allora la sua natura privilegiata o chirografaria poco conta, o il prestito non è rimborsato nella misura garantita e la garanzia sarà giocoforza oggetto di escussione e con essa la trasmutazione del chirografo in privilegio.
E allora, il credito sotto il profilo economico – che è quello che conta – è sostanzialmente un credito privilegiato ancor prima dell’escussione, poiché l’escussione è un evento inevitabile. L’unica variabile è quella temporale, cioè quando in concreto la banca si rivolgerà, dopo l’inadempimento del suo debitore, al garante per recuperarlo, ovviamente nei limiti della quota garantita» [enfasi aggiunta in questa sede]
La ragione necessitata di non incorrere in una contestazione di aiuti di Stato da parte della Commissione UE, dunque, mi era ben nota, come ho scritto nella mia replica a critiche di altro segno.. Ciò che contestavo era il bizantinismo (il miracolo delle nozze di Cana) del meccanismo, di cui ben si poteva fare a meno considerando il credito super privilegiato ab origine, dato che economicamente tale è.
Quanto sopra ove fosse sfuggita la seconda parte delle mie non equivoche, per quanto criticabili, affermazioni.
13 Ottobre 2025 23:35
Non è vero che la ratio non c’è. La ratio c’è o, quantomeno, sembra esserci.
Da lì in avanti il ragionamento non fa una piega e diventa anzi più efficace, proprio perché poggia su una base più forte (ovviamente non mia, ma elaborata dalla Cassazione e, in particolare, dal prof. Dolmetta)
17 Ottobre 2025 0:20
Premessa
Provo a replicare alle diverse critiche ed eccezioni che sono state formulate al mio intervento iniziale, non senza aver prima sgombrato il campo da un equivoco: non ho mai sostenuto che MCC o Sace non potessero transigere i loro crediti di regresso super privilegiati. Mi ero già espresso in modo chiaro nella risposta data al collega Carlo Pirozzi. Né poteva essere diversamente, avendo speso fiumi d’inchiostro sulla transigibilità dell’IVA. Infatti, mi si può rimproverare tutto, ma non di non essere testardamente coerente.
La cornice normativa e la sua ratio
Le disposizioni sui finanziamenti garantiti dallo Stato sono state così ricostruite dalla Corte di cassazione con la sentenza 10 aprile 2024, n. 9657:
Dunque, secondo la ricostruzione del giudice di legittimità, la surrogazione è stata concepita dal legislatore come mezzo per recuperare al bilancio statale risorse pubbliche originariamente impegnate in interventi di sostegno pubblico all’economia.
Giova, allora, ricordare che costituisce aiuto di Stato qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza.
La previsione della surroga, quindi, accompagnata da un diritto di prelazione quasi assoluto risponde(va), proprio alla necessità evitare ogni contestazione in tal senso da parte della Commissione UE. Se così è, predicare la legittimità della rinuncia al diritto di surroga da parte dell’ente statale non può non apparire una pericolosa fuga in avanti che porterebbe la norma, così applicata in concreto, sotto la lente UE.
Né può autorizzare una simile declinazione la struttura irrazionale della disposizione da me denunciata nell’avvio del blog.
Analogamente pericoloso sarebbe forzarne la ratio, poiché non sarebbe la prima volta che la condanna da parte della Corte di Giustizia UE perviene a seguito della contestazione di un uso del pubblico incentivo in modo difforme rispetto alle disposizioni normative che lo avevano introdotto.
Dal momento che tale attesa sarebbe quanto meno dubbia, penso anche che quel professionista avveduto darà conto, pure, delle ragioni per cui l’ente pubblico garante abbia interesse a rinunciare alla surroga.
Non solo, il piano darà anche conto di come ottenere, nell’ambito delle trattative della Composizione negoziata, tale rinunzia.
Ed allora dovrebbe confrontarsi con lo scenario alternativo, spiegando perché in caso di sottomissione dell’impresa alla LG il garante pubblico resterebbe con un “mucchio di mosche in mano” nonostante il suo credito sia assistito da un “super” privilegio generale.
Da questo punto di vista, non è possibile escludere che al di fuori dell’id plerumque accidit si possa verificare che il secondo privilegio generale non sia soddisfatto nell’ambito di una LG, ma non è possibile legittimare una linea di condotta generale sulla base di un’eccezione.
Dunque, lato ente pubblico garante occorrerebbe che, ove escusso per l’intero 80%, esso non possa recuperare dalla LG neppure un solo euro in più di quanto il piano prevede di destinare alla banca garantita in qualità di creditore chirografario, considerando che nella ipotetica LG il soddisfacimento degli altri creditori chirografi sarebbe postergato al proprio credito di regresso.
Ciò potrebbe essere obiettivamente possibile in astratto, ma, anche in tale residuale ipotesi, si dovrebbe tenere conto di una ulteriore circostanza: ossia che alla medesima ristrutturazione potrebbe pervenirsi per il tramite di un concordato preventivo, dove la ricchezza dovrebbe essere distribuita secondo il doppio meccanismo della priorità assoluta sul “valore di liquidazione” e della priorità relativa sul “valore eccedente.
Col che il compito del consulente dell’impresa in crisi – se avveduto - si complicherebbe ulteriormente non poco. Stante la collocazione prioritaria del credito di regresso lo Stato garante avrebbe, infatti, interesse – anche a sollievo delle responsabilità dei propri funzionari – che la distribuzione delle risorse avvenisse sotto l’occhiuto controllo del tribunale e non del solo esperto, con cui, per altro, non avrebbe mai neppure parlato . Non va dimenticato in proposito che, contrariamente a quanto accade per i tributi – che hanno un grado di protezione inferiore -, la rinuncia al diritto di regresso non troverebbe conforto in nessun tipo di attestazione terza di convenienza.
Possiamo ora passare alla seconda questione, ossia come prevedere, nel piano, di ottenere il consenso del garante pubblico.
Mi par di capire – ma posso aver male interpretato – che del consenso del garante se ne dovrebbe occupare la banca garantita, dato che si è affermato che il garante non può essere chiamato al tavolo delle trattative, o, comunque, avrebbe diritto a non parteciparvi, se non previamente escusso. E di escussione non se ne vuol sentir parlare. Qui si aprono questioni estremamente delicate.
Da un lato ci si verrebbe a trovare difronte a un piano la cui ragionevole perseguibilità dipenderebbe dalla rinuncia alla surroga da parte del garante pubblico, senza che la rinuncia sia oggetto di trattativa nell’ambito della Composizione negoziata. Un’antinomia insuperabile, almeno a mio parere, poiché eversiva della stessa natura della CN, che pretende un negoziato trasparente, condotto secondo principi di buona fede e correttezza, sotto la regia dell’esperto.
Dall’altro, quest’ultimo sarebbe privato degli strumenti necessari a valutare se, lato garante pubblico, si siano fatti, o no, progressi verso la condivisione del piano che, rammentiamoci, prevederebbe una rinuncia totale al credito di regresso. L’esperto dovrebbe fidarsi delle percezioni de relato della banca garantita, ma, sempre a mio parere, ove si affidasse al racconto di un terzo violerebbe gravemente il proprio mandato.
Quanto sino a questo momento argomentato mi porta a ritenere che un piano di ristrutturazione che fondi le sue possibilità di successo su un’attesa rinuncia di un creditore eventuale che non partecipa alle trattative della CN sia un piano quanto mai “ballerino”.
A mio parere, quindi, sarebbe in ogni caso preclusa ogni possibilità di ricorrere al concordato semplificato per assenza di buona fede nelle trattative.
Non solo. Se fossi il curatore della successiva dichiarata LG svolgerei nei confronti del professionista e dell’esperto quantomeno l’eccezione di inadempimento e, ove ne ricorressero le condizioni, ipotizzerei a loro carico, nella relazione ex art. 130 CCII, anche il concorso in bancarotta, se non altro di carattere preferenziale per i pagamenti effettuati in favore di creditori chirografari in presenza di un rischio concreto del possibile insorgere di un credito statale super privilegiato, lasciando in disparte eventuali super compensi percepiti dal consulente.
Prima di affrontare temi “mercatistici”, fossi io il “ristrutturatore” di turno, pondererei, quindi, con grande prudenza il confezionamento di un piano che prevedesse contemporaneamente la rinuncia al regresso dell’ente pubblico garante e la sua non partecipazione al tavolo delle trattative della CN.
La banca garantita all’80% non ha particolare interesse – salvo nell’ipotesi di una proposta di soddisfacimento almeno pari a tale percentuale, con pagamento, per altro, illico te immediate – ad accettare trattamenti inferiori e, per di più rateizzati, e promettere, al contempo, di ottenere la rinuncia al regresso del garante.
Escutere la garanzia sarebbe, al contrario, il comportamento più naturale secondo le prassi di mercato.
Di contro per MCC/Sace il regresso assistito dal super privilegio costituirebbe la condotta mercatistica tipica.
Al contrario si pretende che un piano di risanamento possa fondare la sua ragionevolezza sull’assunzione che dei soggetti economici professionali – lasciando in totale disparte gli eventuali obblighi giuridici che incombono su di loro – agiscano al di fuori delle regole di mercato, facendo recedere i loro interessi adeguatamente tutelati dalla legge difronte a quelli dell’impresa in crisi.
Occorre, dunque, che si spieghino le ragioni perché ciò possa ragionevolmente accadere.
Siamo al solito: “il salvataggio dell’impresa in crisi è bene in sé” e prevale su ogni altro “bene della vita” o interesse economico, che, al suo cospetto, devono recedere anche in una posizione più deteriore rispetto a quella che le regole del concorso gli attribuirebbero, ove il concorso si aprisse.
Come, però, ho più volte sostenuto, se nell’ambito degli strumenti giudiziali per il superamento della crisi possono ravvisarsi norme (che a me non piacciono) che legittimano l’affermazione che il salvataggio dell’impresa costituisce un valore superiore, è indubbio come tale super-valore trovi dei limiti insuperabili nelle disposizioni che regolano quegli istituti.
Ne consegue che lo stesso non può dirsi riguardo alla CN dove sono assenti regole di concorso e dove ciascun creditore ha solo l’obbligo di partecipare alle trattative secondo principi di buona fede e correttezza, ma non di aderire alle proposte del proprio debitore, se non perché le giudica conformi ai propri migliori interessi rispetto a quella concreta situazione.
Il primo dato che colpisce è l’entità, in valore assoluto, delle escussioni: 6 miliardi, a cui si deve aggiungere un altro 1 miliardo e spiccioli perso dalle banche, trasferiti a imprese che nell’arco di un quinquennio sono finite in default.
Da questi dati emerge che ove gli enti garanti rinunciassero al regresso si consoliderebbe un intervento a sostegno di imprese, poi “fallite”, di entità tale da non poter non essere considerato un aiuto di Stato, con l’aggravante che così ingenti risorse pubbliche, diversamente destinabili alla sanità pubblica, sarebbero state assegnate a imprese che, con ogni probabilità, si trovavano in difficoltà già al momento dell’ottenimento del finanziamento assistito dalla garanzia statale.
Ecco perché ipotizzare che il garante pubblico rinunci al diritto di regresso verso l’impresa in CN verrebbe a costituire una seconda violazione del divieto agli aiuti di Stato.
Ed ancora, dall’articolo del Corriere della Sera emerge anche della volontà del governo di porre un freno al rilascio delle pubbliche garanzie a sostegno delle imprese, sicché ipotizzare, in un quadro di revisione dello strumento stesso, che lo Stato rinunci al diritto di regresso assistito dal super privilegio, sarebbe ulteriormente assai imprudente.
🔶 🔶 🔶
A voi la parola, dunque…
Il blog meriterebbe di diventare almeno un webinar.
Ci vorrebbe un moderatore di eccezione e un eccellente esperto di conclusioni.
Apprezzo lo sforzo interpretativo di Giovanni che prova a difendere la sua onorevole tesi indossando talvolta il cappello della UE e altra volta quello della Corte dei Conti, sempre quello di paladino delle casse dello Stato.
Io, da Napoli, volo molto più basso e anzi resto con i piedi molto per terra in quanto sono in attesa che MCC validi una delibera bancaria che ha accettato uno stralcio al 55%.
In tale caso il piano dimostra l'estrema convenienza sia per la banca che per il creditore pubblico dell'accordo transattivo.
Secondo le disposizioni operative nei 30+10 giorni il deliberante di MCC può decidere se aderire all'accordo oppure no.
E allora nel lasciare la discussione (con la speranza nel cuore) vi chiedo: "chi sarebbe responsabile dei minori introiti per tutti di una liquidazione giudiziaria qualora questa si aprisse a seguito del diniego di MCC ?
Se vi siete trovati a darvi la mia stessa risposta provate a rileggere Giovanni :
" E allora, il credito sotto il profilo economico – che è quello che conta – è sostanzialmente un credito privilegiato ancor prima dell’escussione, poiché l’escussione è un evento inevitabile. L’unica variabile è quella temporale, cioè quando in concreto la banca si rivolgerà, dopo l’inadempimento del suo debitore, al garante per recuperarlo, ovviamente nei limiti della quota garantita»
Ebbene potreste arrivare alla mia medesima conclusione (che molto probabilmente differente da quella di Giovanni e cioè:
1) L'escussione non è affatto inevitabile in quanto in caso di accettazione della proposta da parte di MCC non vi sarà una escussione totale (che legittimerebbe l'automatica azione di regresso).
2) L'espressione "rinuncia al regresso" di cui si è più volte parlato va correttamente inquadrata come accettazione di una minore perdita per effetto dell'accordo della banca con il creditore.
Speriamo di vederci dal vivo (nel caso a Roma sede di Unioncamere per il quarto anniversario della CNC il 13 novembre 2025). Diversamente l'avvocato Pezzano ci potrebbe organizzare un webinar ???
Scherzo
Un caro saluto in stima a tutti i blogger
17 Ottobre 2025 10:54
Il blog meriterebbe di diventare almeno un webinar.
Ci vorrebbe un moderatore di eccezione e un eccellente esperto di conclusioni.
Apprezzo lo sforzo interpretativo di Giovanni che prova a difendere la sua onorevole tesi indossando talvolta il cappello della UE e altra volta quello della Corte dei Conti, sempre quello di paladino delle casse dello Stato.
Io, da Napoli, volo molto più basso e anzi resto con i piedi molto per terra in quanto sono in attesa che MCC validi una delibera bancaria che ha accettato uno stralcio al 55%.
In tale caso il piano dimostra l'estrema convenienza sia per la banca che per il creditore pubblico dell'accordo transattivo.
Secondo le disposizioni operative nei 30+10 giorni il deliberante di MCC può decidere se aderire all'accordo oppure no.
E allora nel lasciare la discussione (con la speranza nel cuore) vi chiedo: "chi sarebbe responsabile dei minori introiti per tutti di una liquidazione giudiziaria qualora questa si aprisse a seguito del diniego di MCC ?
Se vi siete trovati a darvi la mia stessa risposta provate a rileggere Giovanni :
" E allora, il credito sotto il profilo economico – che è quello che conta – è sostanzialmente un credito privilegiato ancor prima dell’escussione, poiché l’escussione è un evento inevitabile. L’unica variabile è quella temporale, cioè quando in concreto la banca si rivolgerà, dopo l’inadempimento del suo debitore, al garante per recuperarlo, ovviamente nei limiti della quota garantita»
Ebbene potreste arrivare alla mia medesima conclusione (che molto probabilmente differente da quella di Giovanni e cioè:
1) L'escussione non è affatto inevitabile in quanto in caso di accettazione della proposta da parte di MCC non vi sarà una escussione totale (che legittimerebbe l'automatica azione di regresso).
2) L'espressione "rinuncia al regresso" di cui si è più volte parlato va correttamente inquadrata come accettazione di una minore perdita per effetto dell'accordo della banca con il creditore.
Speriamo di vederci dal vivo (nel caso a Roma sede di Unioncamere per il quarto anniversario della CNC il 13 novembre 2025). Diversamente l'avvocato Pezzano ci potrebbe organizzare un webinar ???
Scherzo
Un caro saluto in stima a tutti i blogger
Da liberale, mai qualificazione mi fu più gradita!
20 Ottobre 2025 11:01

