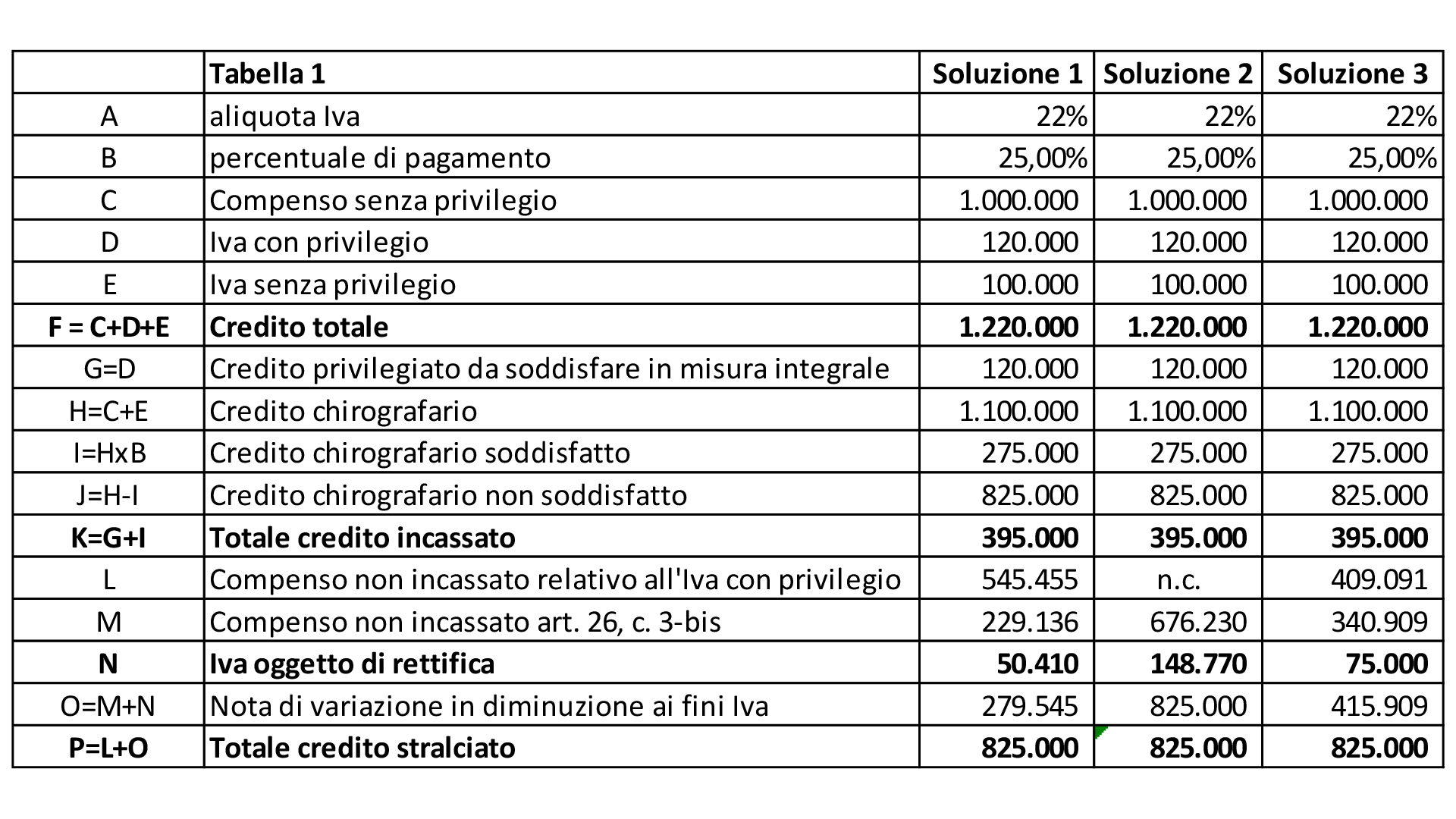Né il comma 3 bis né il comma 10 bis dell’art. 26 citano il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio del debitore, disciplinato dall’art. 25 sexies del Codice della crisi, e ciò è evidentemente dovuto al fatto che anche il testo di detta norma (al pari di quanto accaduto per l’art. 88, comma 4 ter, del TUIR) è stato scritto anteriormente all’introduzione nell’ordinamento di tale procedura e non è stato ancora organicamente adeguato ai nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi. Con l’art. 9 della già menzionata Legge Delega, il legislatore ha disposto che il Governo deve provvedere a estendere a tutti gli istituti disciplinati dal Codice della crisi l’applicazione delle disposizioni dell’art. 26, commi 3 bis, 5, 5 bis e 10 bis, del Decreto IVA, ma al momento la suddetta delega è ancora in attesa di attuazione e l’applicazione del comma 3 bis dell’art. 26 del Decreto IVA è già stata espressamente prevista dal D.L. n. 13/2023 solo con riguardo alla composizione negoziata della crisi d’impresa.
Ciononostante non può revocarsi in dubbio che anche il concordato semplificato liquidatorio sia una procedura concorsuale e, in particolare, che si tratti di una procedura equiparabile, relativamente agli effetti che produce, al concordato preventivo liquidatorio: ne discende quindi che, a parere di chi scrive, è a esso direttamente applicabile il disposto del già citato comma 3 bis, a norma del quale il creditore può emettere una nota di variazione IVA a seguito dell’ammissione del debitore a una procedura concorsuale.
È del resto del tutto naturale che, con il D.L. n. 13/2023, il legislatore si sia preoccupato di estendere, mediante un’apposita norma, la possibilità di emissione della nota di variazione di cui al citato comma 3 bis alla composizione negoziata della crisi e non anche al concordato semplificato: la composizione negoziata della crisi non è certamente una procedura concorsuale e pertanto la diposizione recata dal citato comma 3 bis, in quanto riferita alle “procedure concorsuali”, non sarebbe stata a essa di per sé applicabile in assenza di un’apposita norma, qual è quella introdotta con il menzionato decreto-legge, che ne prevedesse espressamente l’estensione anche a tale “percorso” (così è infatti definita la composizione negoziata nella stessa relazione illustrativa del provvedimento con cui è stata introdotta nell’ordinamento della crisi); invece, come si è già detto e si vedrà ancora, il concordato semplificato costituisce una procedura concorsuale e pertanto il disposto del citato comma 3 bis è a esso direttamente applicabile in quanto “procedura concorsuale”, senza necessità di una ulteriore norma che lo preveda mediante un’integrazione di cui non vi è bisogno.
Inoltre si è riferito nel paragrafo 3.2. che il comma 3 bis dell’art. 26 è stato interpretato dall’Agenzia delle Entrate quale disposizione che consente di “anticipare” l’emissione della nota di variazione in diminuzione al momento di apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, con riguardo a tutti gli altri istituti disciplinati dal Codice della crisi non menzionati da tale norma, opera la regola generale sancita dal comma 2 dell’art. 26, per cui il diritto di recuperare l’IVA non riscossa decorre dal momento dell’omologazione della procedura che determina il venir meno parziale o totale dell’obbligazione giuridica in capo all’impresa debitrice.
Deve pertanto ritenersi che il diritto del creditore di emettere la nota di variazione di cui trattasi sussista anche nel caso del concordato semplificato liquidatorio sulla scorta dei seguenti presupposti:
i) ove si ritenga, com’è certamente da ritenersi, che il concordato semplificato liquidatorio sia una procedura concorsuale (in particolare da assimilare, ai fini di cui trattasi, al concordato preventivo liquidatorio), il suddetto diritto sussiste in virtù della diretta applicazione del comma 3 bis dell’art. 26, che appunto alle procedure concorsuali fa riferimento, nel qual caso il suddetto diritto spetterebbe a decorrere già dalla data di ammissione del debitore alla procedura di concordato semplificato;
ii) ove si ritenga invece di dover escludere, anche se non si vede come, che il concordato semplificato liquidatorio sia una procedura concorsuale, il suddetto diritto dovrebbe sussistere in base alla regola generale discendente dal comma 2 dell’art. 26, con decorrenza dalla data di omologazione del concordato semplificato (per il motivo esposto nel successivo paragrafo 4.3.).
Per i motivi esposti è quindi da ritenersi sussistente il diritto del creditore ad emettere - nei confronti del suo cessionario/debitore - una nota di variazione IVA in diminuzione corrispondente all’importo dei suoi crediti non recuperabile a seguito dell’ammissione del debitore al concordato semplificato liquidatorio, ovvero a seguito della omologazione di tale procedura.
Resta però da stabilire se il debitore abbia l’obbligo, in sede di liquidazione periodica dell’imposta, di registrare a debito le note di variazione in base alla regola generale posta dal primo periodo del comma 5 del citato art. 26, rilevando un debito IVA di ammontare pari all’imposta rettificata nei suoi confronti mediante le stesse, ovvero se possa beneficiare dell’esonero da tale obbligo stabilito dal secondo periodo del medesimo comma 5.
Al riguardo si è già osservato che, anteriormente alle modifiche recate all’art. 26 del Decreto IVA dal D.L. n. 73/2021, l’Agenzia delle Entrate - con la risoluzione n. 155/E del 12 ottobre 2001 - aveva affermato in via interpretativa che l’emissione di una nota di variazione in diminuzione da parte del creditore di un’impresa fallita non potesse determinare l’inclusione del corrispondente credito erariale nel riparto finale dell’attivo, da considerare ormai definitivo. Del pari, con la risoluzione n. 161/E del 17 ottobre 2001 l’Agenzia aveva precisato che l’emissione di detto documento, successivamente alla chiusura del concordato preventivo con garanzia o con cessione dei beni, non potesse comportare per il debitore concordatario l’obbligo di rispondere verso l’erario del relativo debito per IVA, in quanto l’effetto esdebitatorio di cui all’art. 184 della legge fallimentare interessava anche la quota del credito rappresentata dall’IVA dovuta a titolo di rivalsa.
Ebbene, in virtù dell’applicazione dell’art. 117 del Codice della crisi, richiamato dal comma 8 del successivo art. 25 sexies, le medesime considerazioni (quantomeno con riguardo alle note di variazione in diminuzione ricevute a procedura omologata) sono parimenti riferibili al concordato semplificato liquidatorio, con la cui omologazione si produce il suddetto effetto liberatorio e la cristallizzazione dei debiti da soddisfare. Ne discende che anche in quest’ultima procedura non pare sussistere, in capo al debitore, l’obbligo di rispondere verso l’erario del debito che in via ordinaria, cioè in assenza di una procedura concorsuale, l’emissione della nota di variazione IVA da parte del creditore produce nei confronti del debitore.
Indipendentemente da questo motivo, come già riferito in un’altra occasione[42], sussistono ulteriori ragioni per ritenere che relativamente al concordato semplificato liquidatorio, trovano comunque applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 bis, 5 e 10 bis, sebbene tale procedura non sia (ancora) menzionata in tali norme.
Giova al riguardo far di nuovo riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E/2021, secondo cui l’esonero dalla registrazione a debito della nota di variazione in diminuzione non riguarderebbe gli accordi di ristrutturazione dei debiti e i piani attestati, trattandosi di istituti non “qualificabili come procedure concorsuali in senso stretto, in quanto mancano sia del carattere della ‘concorsualità’, sia di quello dell’‘ufficialità’”, che ricorrono entrambi con riferimento al concordato semplificato.
Infatti, secondo la dottrina e la giurisprudenza – e secondo la stessa Agenzia delle Entrate - il carattere della concorsualità sussiste quando un istituto: i) ha rilevanza nei confronti della totalità dei creditori; ii) prevede l’assoggettamento alla procedura di tutto l’attivo dell’impresa debitrice; iii) prevede l’applicazione, ai fini dell’attribuzione dell’attivo del debitore ai creditori, delle regole del concorso e di quelle dell’ordine delle cause di prelazione; iv) prevede la possibilità del debitore di usufruire di misure protettive e cautelari; v) attribuisce al tribunale il potere di dirigere le operazioni e di omologare la procedura. Il concordato semplificato possiede tutti questi caratteri ed è quindi certamente da considerare una procedura connotata da “concorsualità”.
Il concordato semplificato, inoltre, costituisce una procedura munita del carattere della “ufficialità”, atteso che ai sensi dell’art. 25 sexies del Codice della crisi: i) l’imprenditore deve chiederne l’omologazione al tribunale competente mediante la presentazione di un apposito ricorso, che deve essere comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese (comma 2); ii) il tribunale nomina un ausiliario, che deve esprimere sulla proposta di concordato il proprio parere (comma 3); iii) il tribunale dispone con decreto che la proposta e il parere dell’ausiliario siano comunicati ai creditori (comma 4); iv) i creditori e qualsiasi interessato possono opporsi all’omologazione del concordato entro il termine disposto dal tribunale (comma 4); v) il tribunale omologa il concordato se ricorrono i presupposti stabiliti dal comma 5 e il decreto omologativo è comunicato alle parti, che possono proporre reclamo alla corte di appello (comma 6).
La conclusione secondo cui al concordato semplificato liquidatorio si applica l’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 26 del Decreto IVA rispetta perfettamente la ratio di detta disposizione, la quale - come già evidenziato nel paragrafo 3.7.2. - è costituita dall’esigenza di evitare l’insorgenza, in capo alle imprese che hanno avviato un percorso di risanamento, di un onere aggiuntivo che potrebbe ostacolare la ristrutturazione avviata dal debitore e/o il soddisfacimento dei suoi creditori. Poiché si tratta di una misura di sostegno, è comprensibile che essa sia consentita solo in presenza di atti che attestino sia lo stato di crisi in cui l’impresa che ne beneficia deve trovarsi, sia l’efficacia degli interventi adottati per il superamento di tale stato; da qui deriva la necessità di documenti ufficiali che certifichino la ricorrenza di dette circostanze e che, come si è esposto, nel concordato semplificato trovano la propria fonte proprio nell’Autorità Giudiziaria.
Per queste ragioni è di tutta evidenza che i caratteri della concorsualità e della ufficialità sussistono anche nel caso del concordato semplificato liquidatorio e che quindi esso costituisce una procedura concorsuale, né più né meno come il concordato preventivo liquidatorio: ne discende - in base a quanto affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E/2021 - che non sussiste alcun motivo per non applicare in caso di concordato semplificato l’esonero disposto dall’ultimo periodo del comma 5; così come non sussiste alcun motivo per non applicare al concordato semplificato una disciplina differente da quella stabilita per il concordato preventivo e viceversa.
Questa conclusione non è altresì ostacolata dal disposto del comma 10 bis del citato art. 26, il quale non menziona il concordato semplificato. Si è infatti già evidenziato che lo scopo di tale norma è individuare puntualmente la data a partire dalla quale la nota di variazione IVA può essere emessa, che con riguardo al concordato semplificato può essere agevolmente ricavata dalla disciplina del concordato preventivo e perciò individuata nella data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, da cui decorrono, a norma dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 25 sexies, gli effetti di cui agli artt. 6, 46, 94 e 96 del Codice della crisi[43].
Dalle considerazioni che precedono discende quindi che l’esonero dall’obbligo di annotazione della nota di variazione previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 26 del DPR n. 633/1972 trova applicazione anche per effetto della omologazione del concordato semplificato liquidatorio di cui all’art. 25 sexies del Codice della crisi.
Occorre tuttavia dare atto del fatto che al momento l’Agenzia delle Entrate sembrerebbe essere di diverso avviso, come dimostra la recente risposta a interpello n. 179 del 7 luglio 2025 con cui è stata esclusa la detassazione ai fini delle imposte sui redditi delle sopravvenienze attive da esdebitazione maturate in sede di concordato semplificato, non essendo il suddetto istituto espressamente menzionato nell’art. 88, comma 4 ter, del T.U.I.R.; alla medesima conclusione l’Agenzia potrebbe quindi pervenire con riferimento al comma 3 bis e all’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 26 del Decreto IVA, a causa della mancata menzione del concordato semplificato da parte di dette norme.
Proprio sulla mancata menzione nel testé citato art. 26, del resto, l’Agenzia ha fondato la risposta a interpello n. 9 maggio 2023, n. 324, con cui ha escluso l’applicabilità del citato comma 3 bis alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio regolata dall’art. 14 ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.